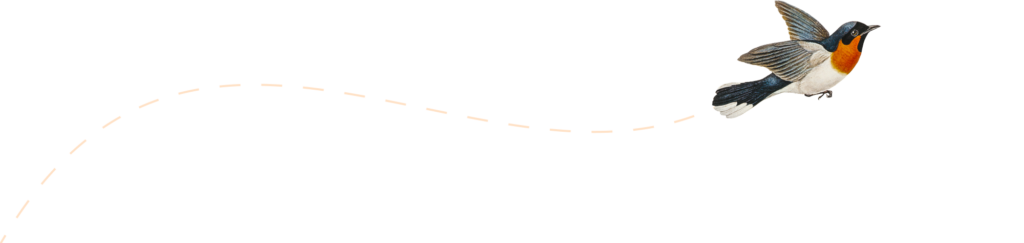Molte cooperative, specialmente quelle di grandi dimensioni, eleggono i Consigli di Amministrazione sulla base della propria articolazione strutturale. Sono cooperative che hanno sedi in territori diversi, o che nascono da processi di fusione fra più cooperative, o che sono ripartite in divisioni di prodotto. In questi casi i regolamenti elettorali fanno in modo che ciascuna articolazione (territoriale, aziendale, di prodotto) abbia la possibilità di esprimere un numero di consiglieri congruo con la dimensione della base sociale dell’articolazione stessa.
Una prima conseguenza di tale scelta è che ci si trova di fronte a organismi composti da decine di consiglieri, e questo è certamente un limite dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia del processo decisionale.
Un’altra conseguenza – meno evidente ma altrettanto critica – sta nel fatto che i consiglieri, in quanto scelti da una base elettorale specifica, possono comportarsi in CdA non tanto come “dirigenti a 360 gradi” della cooperativa, ma come rappresentanti della base sociale che li ha eletti. Tale atteggiamento, se portato alle estreme conseguenze, porta il consigliere a ragionare più da “feudatario” che da “dirigente a 360 gradi”, e a trasformare le discussioni in CdA in una sfiancante mediazione fra interessi (ovvero feudi) contrapposti.
Se il CdA si trasforma in una specie di parlamento, in cui tutti gli interessi specifici devono essere tutelati, il rischio di paralisi è reale. Se il consigliere accantona la difesa degli interessi particolari della propria base elettorale, e decide tenendo come riferimento il bene della cooperativa nel suo insieme, allora il CdA lavora come organo di governo maturo e incisivo. Certo questo può comportare, per il consigliere, la sgradevole accusa di “tradimento” da parte di chi lo ha eletto, ma è un prezzo che va pagato e, in definitiva, una medaglia al valore da appuntarsi al petto.